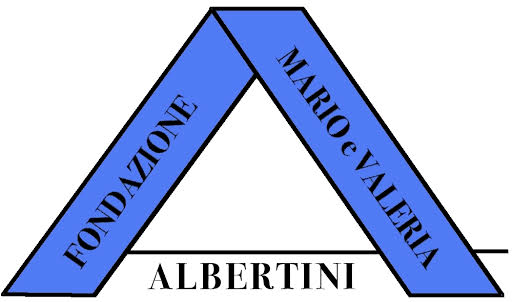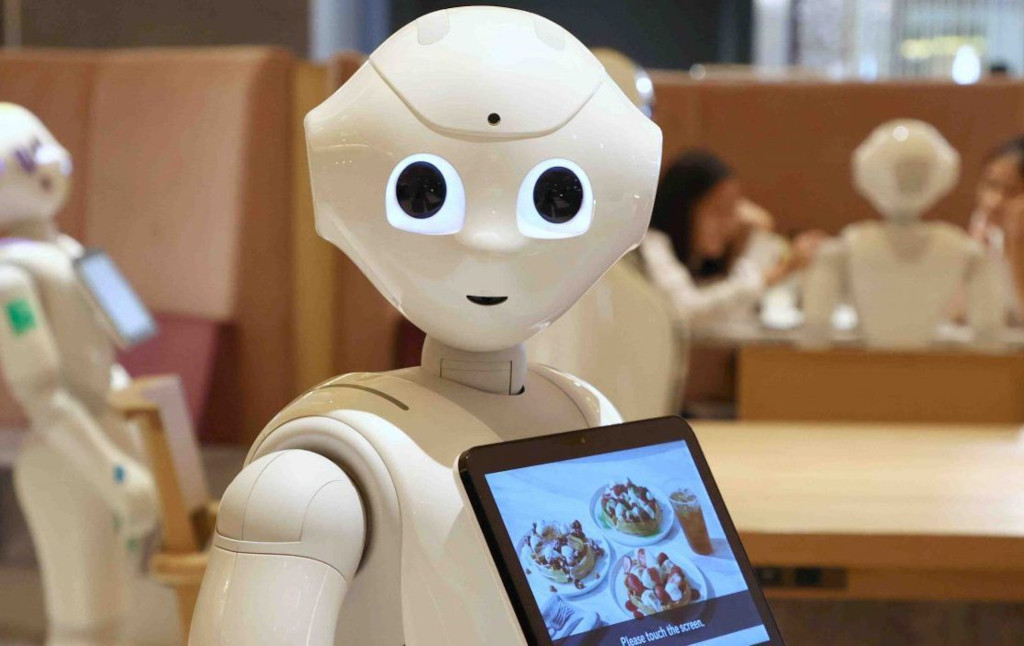Alcuni esperti di studi sullo sviluppo tecnologico avevano pronosticato nel 2001 che solo un paio di grandi compagnie delle telecomunicazioni, la Global Crossing e la 360networks si sarebbero spartite la supremazia nel campo dello sviluppo tecnologico, ma che in un mercato mondiale ultramiliardario non ci sarebbero stati degli sconfitti (Economist 18/07/2002). Nel 2002 entrambe queste aziende erano però finite in bancarotta e ci sono stati numerosi sconfitti: diverse banche, molti azionisti, tanti investitori e molte società. I responsabili politici, a partire dal Presidente George Bush, si impegnarono a rassicurare investitori e cittadini, ma le preoccupazioni sulla tenuta dell’economia non diminuirono, anche perché un’altra bolla si apprestava a scoppiare nel campo delle aziende delle telecomunicazioni, un settore produttivo dieci volte più grande di quello delle dot-com, la bolla speculativa che aveva colpito i mercati finanziari tra il 1995 e il 2001, collegata alla nascita ed alla crescita delle aziende Internet identificate con il dominio “.com”.
Negli anni ’90, insieme all’esplosione di Internet, si diffuse la convinzione che il futuro sarebbe stato dominato da una nuova “autostrada dell’informazione”: reti di fibra ottica e comunicazioni mobili capaci di trasmettere enormi quantità di dati. Le aziende di telecomunicazioni — sia nuove che storiche — avevano investito miliardi di dollari in infrastrutture in tutto il mondo. E gli investitori, tra cui appunto Global Crossing e 360networks, attratti dal potenziale dell’economia digitale, avevano investito sul finire degli anni novanta ingenti somme nel settore, e la loro crisi aveva bruciato capitali sui mercati dieci volte quello delle cosiddette dot.com (le aziende commerciali nate o sviluppatesi verso la fine degli anni novanta a seguito della rivoluzione digitale). Che cosa era successo?
Le compagnie come WorldCom, Global Crossing, Lucent Technologies, Nortel Networks, Qwest, Level 3 e molte altre avevano aumentato enormemente gli investimenti per posare migliaia di chilometri di fibra ottica, e le banche avevano concesso facilmente crediti per finanziare espansioni e fusioni. I titoli delle aziende di telecomunicazioni erano schizzati alle stelle (alcuni aumentarono di valore del 500% in pochi anni). La domanda di servizi Internet intanto cresceva più lentamente del previsto e le reti in fibra costruite in eccesso rimanevano in gran parte inutilizzate. I debiti delle aziende coinvolte crescevano e i ricavi risultavano insufficienti per coprire le spese. Fu così che iniziò una serie di fallimenti spettacolari, come quello di WorldCom (2002), coinvolta in una delle più grandi frodi contabili della storia e della Global Crossing (2002), a seguito di investimenti diventati insostenibili. Aziende come Nortel e Lucent persero addirittura oltre il 90% della loro capitalizzazione. Il settore perse oltre 2 trilioni di dollari di valore di mercato. Ci furono migliaia di licenziamenti e chiusure di filiali e le banche subirono gravi perdite per i prestiti concessi. Poche aziende (come Cisco, AT&T, Verizon, British Telecom) sopravvissero, spesso dopo fusioni e ristrutturazioni.
L’eccesso di fibra ottica posata poté però essere riutilizzato negli anni successivi, favorendo la crescita di Internet ad alta velocità. Questo perché con la fibra ottica, che usa fili di vetro o plastica sottilissimi che trasmettono impulsi di luce, si può raggiungere una velocità di trasmissione di oltre 1 Gbps (fino a decine o centinaia di Giga bps nelle reti moderne), mentre con i classici doppini telefonici in rame si arriva al massimo a 100 Mega bps (e spesso molto meno, a seconda della distanza). Inoltre con la fibra ottica il segnale si degrada pochissimo anche su molti chilometri, mentre con il classico doppino telefonico in rame il segnale si attenua rapidamente e oltre poche centinaia di metri le prestazioni calano molto.
L’Unione europea ha finora svolto un ruolo cruciale nel regolamentare le attività commerciali di un continente che è non solo crocevia del commercio mondiale, ma anche e tuttora uno snodo geopolitico nel confronto tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, oltre che rappresentare un mercato di quasi mezzo miliardo di individui che concorrono nel produrre e consumare beni scambiati ormai su scala globale. E' però mancata una politica industriale continentale, lasciando tutto alla logica del mercato. Fatto questo del resto ben messo in evidenza nei rapporti Draghi su Competitività e Crescita https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AT033.pdf e di Letta sul futuro del Mercato Unico UE, https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf, preparati per la Commissione europea sul futuro dell’Unione Europea. Il problema è che finché l’Europa resta prigioniera della logica del potere di veto non c’è futuro senza un salto politico di tipo federale continentale che renda l'UE capace d’agire.
Bisogna quindi tener presente che il ruolo che può giocare l’esistenza o meno di un vero governo federale a livello continentale è decisivo per orientare, dirigere e finanziare le scelte in campo tecnologico e industriale. Un problema questo già emerso negli anni settanta del secolo scorso, quando Spinelli entrò nella Commissione Europea presieduta da François-Xavier Ortoli (1973–1977), dopo un primo mandato nella Commissione Malfatti (1970–1972). Già allora l’Europa stava affrontando grandi sfide economiche, come la crisi energetica del 1973, le trasformazioni industriali in atto e i primi passi verso una politica tecnologica comune. In quanto commissario responsabile della politica industriale, della ricerca scientifica e tecnologica, degli Affari interni e dello spazio industriale europeo, Spinelli, per evitare frammentazioni tra i paesi membri, propose un vero coordinamento europeo delle politiche industriali nazionali, che portò alla nascita di programmi comuni di ricerca e innovazione, anticipando concetti che più tardi dovevano confluire nei programmi FRAMEWORK dell’UE (come, ma oltre, meglio di “Horizon Europe” tuttora prigioniero della logica del potere di veto dei singoli paesi e di quella dei ritorni delle convenienze economiche in campo nazionale). L’incarico a Spinelli implicava lo sviluppo di grandi progetti tecnologici europei, come nel settore aerospaziale, nel nucleare civile e nell’informatica avanzata. Il problema, già allora, riguardava la difesa dell’autonomia tecnologica europea nei confronti di Stati Uniti, Russia e Giappone. Spinelli promosse l’idea che l’industria e la ricerca dovessero essere strumenti di integrazione politica europea, non solo economica. E fu tra i primi a proporre un piano di unione industriale europea, basato su strategie comuni di innovazione e sviluppo. Del resto basta ricordare quanto successo negli Stati Uniti negli anni 60-70 del secolo scorso, quando il governo federale degli USA, attraverso i suoi dipartimenti, decise di finanziare ricerca e produzione nel settore del silicio rispetto ad altri semiconduttori (da qui il successo delle imprese tuttora attive nella regione della Silicon Valley).
Oggi, o la classe politica, i governi nazionali, i cittadini sosterranno e contribuiranno a far sì che l’Unione europea si doti di un vero governo federale continentale capace d’agire in questo settore ormai cruciale, oppure l’Europa sarà destinata a restare un’espressione geografica nello scacchiere mondiale, in balia delle politiche e delle mire di USA, Cina e Russia. E ad essere marginale e subalterna nell’attuazione di efficaci politiche orientate verso la transizione ecologica. Basti ricordare come, per promuovere il superamento della dipendenza delle nostre economie dal petrolio e promuovere la mobilità elettrica rispetto a quella basata sui combustibili fossili, bisognerebbe essere in grado di incentivare la produzione di batterie ricaricabili al litio, minerale più disponibile in altre regioni del mondo rispetto all’Europa e che, laddove è largamente disponibile come in Groenlandia, tuttora legata ad una vecchia potenza europea come la Danimarca, sta diventando mira di potenze extra europee, come ci ha ben ricordato il Presidente USA Trump.
Il fatto è che, come ci ha ricordato Ludwig Dehio nel 1948 in chiusura del suo libro Equilibrio o Egemonia (ripubblicato nella biblioteca federalista Il Mulino, Bologna, 1988) per gli europei “Questo è il tempo della grazia e del peccato, e il nostro tempo che mai ritorna…”. Appunto: CHE NON RITORNA!