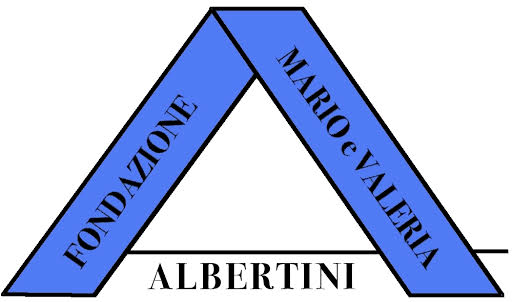Il Green Deal ha visto la luce l’11 dicembre 2019 con la sua presentazione a cura della presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen presentava, segnando l’avvio di una nuova era nella politica climatica e industriale dell’UE. Obiettivo finale: la realizzazione entro il 2050 della neutralità climatica, dando vita ad un’economia sostenibile in grado di trasformare le sfide climatiche e ambientali in opportunità di crescita e in un futuro sostenibile ed inclusivo per i cittadini europei.
Così veniva scritto nella comunicazione del 14 gennaio 2020 della Commissione europea al Parlamento europeo: “Il Green Deal europeo è la risposta dell'Unione europea ai problemi legati al clima e all'ambiente, che rappresentano il compito che definisce la nostra generazione. Si tratta di una nuova strategia di crescita il cui obiettivo è quello di trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che a partire dal 2050 non genererà più emissioni nette di gas a effetto serra, in cui l'ambiente e la salute dei cittadini saranno protetti e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse.” (da COMMISSIONE EUROPEA - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI – Introduzione - Bruxelles, - COM(2020)).
Un’agenda con parametri concreti, tempistiche e previsioni finanziarie, che fanno riferimento a: neutralità delle emissioni gas, decarbonizzazione del settore energetico, produzione, mobilità (ndr.: automotive), agricoltura, edilizia.
Rispetto agli obiettivi di riduzioni delle emissioni fissati, l’Unione europea stava procedendo “sulla buona strada”. Al 2023, le emissioni nette di gas serra dell’Ue sono calate del 37% rispetto al 1990, mentre il Pil aumentava del 68%. L’obiettivo fissato dall’agenda verde europea è di arrivare a un taglio del 55% entro il 2030. Una sforbiciata che sembra essere decisamente alla portata per il Vecchio Continente. Continuando ad attuare i piani nazionali e le politiche comunitarie, l’Ue potrà ridurre le emissioni del 54% entro fine decennio (2030), un solo punto percentuale in meno rispetto all’obiettivo fissato.
Un contesto apparentemente favorevole, tant’è vero che il 1° febbraio 2023 la presidente della Commissione Ue ha presentato il “Green Deal Industrial Plan”, un nuovo piano industriale europeo per un’industria a emissione zero (zero net) con la previsione di un nuovo fondo sovrano comune (oltre a 250 mld del RePowerEu e 100 dalla politica di coesione) per «aumentare le risorse disponibili per la ricerca a monte per l’innovazione e per i progetti industriali strategici».
Sotto il profilo sostanziale la Commissione si era proposta di:
- sostenere e accelerare una transizione verde ed energetica sostenibile;
- accompagnare la transizione digitale; promuovere la ricerca, l’innovazione e il potenziamento del capitale umano;
- sviluppare i settori strategici;
- sostenere la diffusione di tutte le fonti di energia rinnovabile;
- concedere aiuti per le tecnologie meno mature, come l’idrogeno rinnovabile, senza una gara d’appalto, a condizione che siano previste alcune salvaguardie per garantire la proporzionalità del sostegno pubblico;
- incentivare gli investimenti che portano a una riduzione significativa delle emissioni includendo massimali di aiuto più elevati e calcoli semplificati;
- sostegno degli Stati membri alla produzione di batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e cattura e stoccaggio del carbonio, e alle relative materie prime critiche necessarie per la produzione.
Un percorso che, contrariamente alle iniziali aspettative, ora sta segnando il passo, messo in crisi dal concorso di cause esogene (sul piano internazionale), in particolare:
- la fine di un modello di globalizzazione (commercio internazionale e le catene globali del valore) e l’insorgere di politiche nazionali protezionistiche;
- il conflitto bellico con cui Putin tiene in stallo l’Ue, dopo averla obbligata ad una forzata e rapida conversione negli approvvigionamenti delle fonti energetiche ed, ora, ad un drenaggio finanziario per sostenere la resistenza ucraina;
- la guerra dei dazi portata avanti da Trump per depotenziare l’export europeo e condizionare politicamente i singoli governi nazionali;
- l’opportunismo politico e l’aggressività commerciale della Cina.
Al contempo si è andato configurando il concorso di cause endogene alla stessa Unione e riconducibili ai nuovi equilibri politici all’interno del Parlamento europeo e a nuove maggioranze partitiche e di governo in singoli paesi membri.
Anzitutto, l’avanzata delle forze di destra all’interno del Parlamento europeo ha cambiato gli equilibri politici. Mentre nel 2019 le elezioni europee avevano espresso un Parlamento relativamente progressista con i Verdi in una posizione di rilievo, nel 2024 si è registrata un’inversione di tendenza. Esemplificativo è il caso del deputato europeo di estrema destra olandese Bert-Jan Ruissen e di suoi colleghi che hanno avviato azioni volte a rallentare l’attuazione del Green Deal, sostenendo che rappresenterebbe una minaccia per la giustizia sociale e la stabilità economica.
Non solo l’estrema destra si oppone, anche il Partito popolare europeo (Ppe) ha sollevato dubbi sulle politiche ambientali ritenendole dannose per gli agricoltori, l’approvvigionamento alimentare e la stabilità economica. A gennaio, dopo una riunione dei leader del Ppe, il partito ha chiesto alla Ursula Von der Leyen, di cui è espressione, di bloccare per due anni le direttive sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale e sulla due diligence. Pur da contestualizzare nei toni, essendo stata pronunciata in una assise di partito, così si è espresso il Presidente del Ppe, Manfred Weber: «Dove sarebbero oggi la nostra industria e i nostri posti di lavoro, se non avessimo fermato la politica climatica ideologica alla Frans Timmermans?»
Anche leader di importanti capi di governo pressano Bruxelles per un ripensamento, non solo sui tempi, della transizione verde.
Il primo ministro polacco Donald Tusk, durante il suo discorso al Parlamento europeo (22 gennaio 2025 in apertura di semestre) per presentare le priorità della Polonia, ha inveito contro il Green Deal, sostenendo che alcuni regolamenti ambientali introdotti dall’Ue negli ultimi cinque anni sono responsabili dei prezzi energetici “proibitivi” che danneggiano la competitività del blocco rispetto a USA e Cina.
Più recentemente anche i governi nazionali, tra cui quello tedesco, francese e italiano, sotto le pressanti pressioni delle industrie nazionali - sopra tutte le altre quelle del settore automobilistico - e degli agricoltori, stanno ponendo freni alla transizione verde.
Già alcuni mesi fa il presidente francese Emmanuel Macron, incontrando a Versailles i rappresentanti del mondo imprenditoriale, ha dichiarato che la regolamentazione andrebbe cancellata, allineandosi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz che aveva precedentemente definito il rinvio della direttiva “al massimo un primo passo” e la sua “completa abrogazione” come “il passo logico successivo”. Anche la premier italiana lamenta l’approccio ideologico da parte della Commissione europea che “produce danni al tessuto economico industriale” del paese e “la credibilità stessa dell’Unione europea”.
Dall’ottobre 2023, in diversi Capi di Stato e di governo dell’Ue chiedono una “pausa normativa” nell’attuazione del Green Deal, temendo conseguenze economiche e sociali, all’ottobre 2025, in cui il Consiglio europeo accoglie “con favore l’intenzione della Commissione di portare avanti la revisione prevista dal regolamento sulle prestazioni di CO₂ per auto e furgoni” e ne ha chiesto “la rapida presentazione, tenendo conto della neutralità tecnologica e del contenuto europeo”, la Commissione europea ha mostrato segni di cedimento. “Dulcis in fundo”: la Commissione di Von der Leyen ha sostituito il termine “Green Deal” con “Clean, Just and Competitive Transition”, suggerendo una maggiore attenzione ai bisogni dell’industria.
Di contro, sul fronte del sostegno a proseguire nella transizione verde, si sono espresse sette associazioni e organizzazioni tra le più rappresentative - da Legambiente a Greenpeace, da Kyoto Club a Transport & Environment - che, in occasione del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre, hanno lanciato un appello congiunto ai governi europei affinché il Green Deal non venga smantellato: “La richiesta congiunta dei governi italiano e tedesco alla Commissione europea, affinché sia rivista la normativa sulla riduzione delle emissioni per auto e van, rappresenta un atto inedito, per forza e gravità, mirato a smantellare il Green Deal. L’intento esplicito è di indebolire uno dei principali pilastri della politica industriale e climatica dell’Unione”. (Sette ONG denunciano la "deriva" Ue contro il Green Deal - Eunews)
Secondo i firmatari, non è indebolendo le regole o spostando obiettivi come quello del 2035 che l’Europa diventerà più competitiva: “Ma non è indebolendo le regole, rallentando la transizione o rinunciando alla sfida dell’innovazione che l’Europa diventerà più competitiva. Non sarà spostando una data – quella del 2035 – o rivedendo i regolamenti per renderli meno ambiziosi che si risolverà alcun problema: né climatico, né occupazionale, né industriale. È esattamente il contrario: ogni passo indietro ci farà perdere tempo e terreno rispetto alle economie che stanno già costruendo il futuro puntando sulle tecnologie pulite.”
In questi ultimi giorni stiamo assistendo a segnali e decisioni di rinnovata proattività da parte delle Istituzioni europee.
Secondo quanto anticipato dall’Agenzia “Ansa.it Europa”: “E’ attesa per fine novembre la presentazione da parte della Commissione Ue del pacchetto normativo di attuazione del “Clean Industrial Deal”. L’iniziativa - attesa per il 25 del mese [ndr. novembre],secondo l’ultimo ordine del giorno dei commissari - comprenderà una strategia per l’investimento di energia pulita, un pacchetto dedicato alle reti, una legge per lo sviluppo industriale (Industrial Accelerator Act) e la strategia già annunciata per la filiera delle batterie.
per sostenere la produzione industriale pulita nell'Ue, di cui un'ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro nell'ambito dell'attuale bilancio comune.” (Da reti a batterie, in arrivo misure Ue per il Clean Industrial Deal - Sviluppo sostenibile e digitale - Ansa.it 17.10.2025).
Dopo un accesissimo negoziato diplomatico durato pressoché 24 ore, il Consiglio dell’Ambiente, riunitosi a Bruxelles mercoledì 5 novembre, ha raggiunto un compromesso sugli obiettivi climatici del 2040. Oggetto del negoziato tra i governi in vista del prossimo confronto col Parlamento la proposta della Commissione europea che prevedeva entro il 2040 una riduzione delle emissioni nocive del 90%, rispetto ai dati del 1990. Un “compromesso” che ha dovuto tener conto di una serie di istanze ed eccezioni d’interesse nazionale mosse da alcuni ministri e che è stato votato a maggioranza qualificata e non all’unanimità.
Nonostante qualche passo in avanti, non possiamo non osservare come in questi due ultimi anni l’Unione europea si è venuta a trovare più volte in una sorta di cortocircuito. Le indeterminatezze e i rallentamenti nella transizione verde mettono in luce l’anacronismo dell’architettura istituzionale dell’attuale Unione europea, impossibilitata nel portare avanti una strategia in questioni affrontabili solo in un ambito sovranazionale e questo perché condizionata dai governi nazionali (leggi: Consiglio europeo) che mirano a soddisfare compiacimenti elettorali che rispondono a scadenze elettorali nel breve periodo.
Il rilievo maggiore è che questa Unione europea manca della necessaria unità politica, di una visione, una governance sovranazionale e di strategie comuni nell’affrontare le sfide strategiche del continente.
L’Unione come eterna assemblea di condominio, è peggio che sbagliata: appartiene ad un’altra epoca. Nei giorni scorsi Mario Draghi ha rivolto un accorato appello: “ ... cos’altro deve accadere, cos’altro deve crollarci addosso? Vogliamo continuare a balbettare o sapremo dimostrarci una civiltà che decide, difende, si rinnova?”.
Ad Oviedo, dal Teatro Campoamor, dove è stato insignito del prestigioso Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale, Draghi ha fatto una sua proposta per superare l’impasse politico-istituzionale dell’Ue pur restando all’interno degli attuali Trattai: “Serve un’Europa che agisca su temi specifici e condivisi, guidata da coalizioni di volenterosi”, vale a dire, un federalismo europeo flessibile e tematico, capace di superare i limiti dei trattati senza doverli modificare.
Una opzione ripresa dall’ On. Sandro Gozi, parlamentare europeo di Renew Europe e già presidente dell’Unione dei federalisti Europei (UEF) nel suo “Rapporto su allargamento e riforme”, approvato lo scorso 22 ottobre dal Parlamento europeo. L’On. Gozi ha fatto anche presente che il Parlamento europeo ha già messo sul tavolo del Consiglio europeo una proposta di riforma complessiva dei Trattati e “per avviare un dibattito sule riforme istituzionali, basta la maggioranza semplice. Basta che 14 leader al Consiglio europeo decidano che è arrivato il momento di discutere di riforme istituzionale e il processo formale viene avviato”.
C’è allora da chiedersi insieme a Mario Draghi: "Quanto grave deve diventare una crisi affinché i nostri leader uniscano le forze e trovino la volontà politica di agire?".