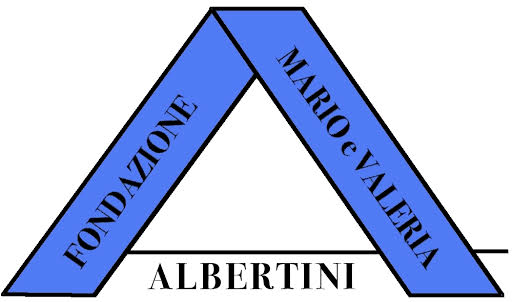Il 1° ottobre scorso il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, riferendo alla Camera su investimenti e riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha detto che: “Nell’insieme, vi è un 96 per cento di progetti pienamente attivi, con un impegno di spesa di 148 miliardi”. “Gli obiettivi del PNRR con la rata che abbiamo raggiunto, la settima, sono 334 raggiunti, pari al 54 per cento degli obiettivi determinati.In Europa la media, rispetto agli obiettivi, è pari al 38%. Attualmente sono state erogate risorse, in ragione agli obiettivi raggiunti, pari a 140 miliardi di euro, il 72% della dotazione del piano. Dalle interlocuzioni che ci sono state, in questi mesi, con la Commissione – ha aggiunto Foti – si è lavorato anche per la certificazione del raggiungimento degli obiettivi dell’ottava rata, circa 40 obiettivi, la cui liquidazione dovrebbe avvenire entro alla fine del mese di novembre. Ciò porterebbe ad una situazione che vedrebbe 153 miliardi di euro incassati”.
Alla nota apparentemente ottimistica del ministro, due giorni dopo, ha fatto seguito il “Rapporto di previsione per l’autunno 2025” di Confindustria nel quale emerge in tutta evidenza che senza i benefici del PNRR non ci sarebbe stata la pur minima crescita ma stagnazione. Questi i dati: “L’effetto positivo del PNRR sul PIL è stimato in un +0,8% nel 2025 e un +0,6% nel 2026 ... Questo significa che la dinamica del Pil italiano in assenza di PNRR sarebbe di -0,3% nel 2025 e di +0,1% nel 2026 (-0,2% nel biennio).".
Questo cosa sta a significare? Che il nostro Paese, all’interno della tempesta perfetta (la crisi pandemica Covid, le conseguenze della guerra russo-ucraina, la recente guerra commerciale innescata dal presidente USA, endemica minore competitività), senza il sostegno europeo del “Next Generation EU” in questi ultimi anni si sarebbe trovato ad oscillare tra stagnazione e recessione con gravi ripercussioni sociali.
Il Piano strategico “Next Generation EU”, predisposto all’indomani della pandemia con un budget di 750 miliardi di euro per “un’Europa più forte e resiliente” e che trova concreta declinazione nel PNRR, ha potuto fare solo - ma per fortuna - da “salvagente” per l’economia del Paese.
Nel frattempo, il mondo è andato avanti e come Mario Draghi ci ha ricordato ancora lo scorso 16 settembre, i cittadini e le imprese europee, “Sono delusi dalla lentezza con cui l’UE si muove. Vedono che non riusciamo a tenere il passo con la velocità del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano colto la gravità del momento. Troppo spesso si trovano scuse alla nostra lentezza. Io penso che questo sia compiacimento. Continuare come sempre significa rassegnarsi a rimanere indietro”.
Nella sua comunicazione l’ex presidente della BCE non ha perso l’occasione per sottolineare la necessità di strumenti finanziari comuni per sostenere gli investimenti strategici. “Se riusciremo a concentrare i nostri sforzi, il passo logico successivo sarà considerare il debito comune per progetti comuni, sia a livello UE che tra una coalizione di Stati membri”.
La proposta di Draghi è di percorrere la via del “debito comune per progetti comuni”, anche attraverso una “cooperazione rafforzata” tra “coalizioni di volenterosi” (“ ... il passo logico successivo sarà considerare il debito comune per progetti comuni, sia a livello UE che tra una coalizione di Stati membri, per amplificare i benefici del coordinamento”.
Un dato è certo: i singoli Stati europei non possono più reggere da soli la competizione industriale e commerciale, finanziaria e tecnologica; considerati singolarmente sono sempre più destinati alla marginalità. Così Mario Draghi: “Nel corso dell’ultimo anno ciascuna di queste sfide è diventata più acuta. Il nostro modello di crescita si sta sgretolando, le vulnerabilità aumentano e siamo stati dolorosamente ricordati che l’inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra sovranità”.
D’accordo l’inazione non è più tollerabile. E allora quali le opzioni? Due le opzioni: da un lato, l’“approccio pragmatico verso i problemi”, auspicato da Draghi, percorrendo - di volta in volta - la strada del ricorso al debito comune per progetti comuni. L’altra opzione, che tiene conto di quanto democraticamente chiesto dai cittadini europei all’interno della Conferenza sul futuro dell’Europa e dalla successiva proposta del Parlamento europeo di riforma in senso federale dei Trattati, è quella di un’azione politica per portare il Consiglio europeo a convocare una Convezione, ai sensi dell’Art. 48 del TUE.
Nell’inerzia del Consiglio europeo, siano allora gli Stati che vogliono rafforzare l’integrazione a scegliere lo strumento unitario e previsto dai Trattati e ad avviare la Convenzione; questi stessi Stati dovranno porre tra i temi cruciali al centro del confronto anche quello della creazione di una struttura dell’UE fondata su diversi cerchi di integrazione, dato che sarà inevitabile riuscire ad avanzare a 27 allo stesso passo, ancor di più oggi che aumentano i governi euro-tiepidi e/o euroscettici.