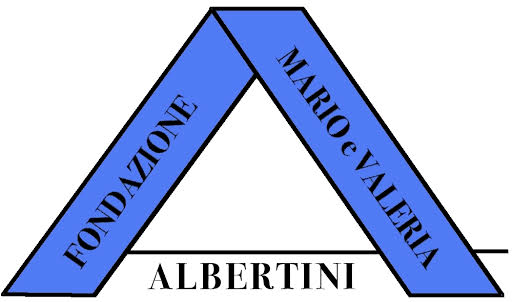Il 19 ottobre 2025 la parte settentrionale dell’isola di Cipro ha eletto, a sorpresa, Tufan Erhürman come Presidente. La particolarità di questa elezione risiede sia nell’ampio scarto di voti che ha determinato la vittoria del nuovo presidente, in opposizione all’uscente Ersin Tatar – circa il 63% contro il 35% – sia, soprattutto nella netta differenza tra i due in merito alla questione cipriota. Erhürman, infatti, si presenta come promotore di istanze riunificatrici con la Repubblica di Cipro, a differenza del suo predecessore che, invece, spingeva per l’affermazione dello Stato turco, in piena vicinanza (o sudditanza) con Ankara.
La divisione dell’isola nelle entità statali della Repubblica di Cipro e della Repubblica Turca di Cipro del Nord trova le sue origini nel secolo scorso, dallo scontro scaturito dall’impresa greca di acquisire l’isola per riunirla alla madrepatria e dall’intervento della Turchia in supporto alla minoranza turca. Il risultato finale è stato una vera e propria occupazione della porzione settentrionale dell’isola con la creazione dello Stato a maggioranza turca, il quale, tuttavia, rimane escluso dalla comunità internazionale e riconosciuto solamente dal governo di Ankara.
La divisione dell’isola tra greco-ciprioti e turco-ciprioti non è soltanto una questione di partizione etnico- religiosa. Essa, infatti, ha delle implicazioni in termini di sicurezza economica ed energetica sia per la Turchia, sia per Cipro e l’Unione Europea, di cui Cipro fa parte. Il controllo di Cipro Nord permette alla Turchia di aumentare la propria proiezione sul Mediterraneo orientale e di accedere alle risorse di idrocarburi ivi situate, a dispetto della Zona Economica Esclusiva (ZEE) reclamata invece da Cipro in accordo alle disposizioni del trattato di Montego Bay (UNCLOS). La presenza turca nel Mediterraneo, negli ultimi anni, è diventata sempre più assertiva, coerentemente con la politica “Blue Homeland” di proiezione di potenza sul mare già teorizzata nel 2006, ponendosi in diretta concorrenza con la Grecia e utilizzando Cipro per estendere i propri confini marittimi, ignorando gli accordi di istituzione delle ZEE stipulati proprio dalla Repubblica di Cipro e i Paesi del Medioriente e contrastando le compagnie estere che operano nell’area sotto licenza cipriota.
L’accesso agli idrocarburi risulta cruciale per l’Europa nell’ottica di diversificare i propri approvvigionamenti energetici, specialmente ora che si cerca di azzerare la dipendenza dal gas russo. La spregiudicatezza di Ankara nei confronti delle convenzioni in materia contribuisce all’erosione del diritto internazionale e contrasta gli interessi energetici dei Paesi europei, contribuendo così all’instabilità nell’area.
La vittoria di Erhürman riapre la possibilità di una ripresa delle trattative per la riunificazione dell’isola nella forma di una convivenza tra le due popolazioni cipriote e di un conseguente alleggerimento delle tensioni. Infatti, l’integrazione politica ed economica dell’isola ridurrebbe le tensioni nel Mediterraneo orientale, creando un contesto più stabile per la cooperazione energetica e la sicurezza marittima. La partecipazione turco-cipriota alle istituzioni di uno Stato organizzato su basi federali permetterebbe di tutelare gli interessi turchi in modo legittimo e istituzionale, mentre l’integrazione regionale favorirebbe nuovi progetti comuni di trasporto del gas verso l’Europa.
In questo frangente, risulta poco presente la voce della stessa Unione Europea. Mancando di un reale potere politico, la partita resta prevalente in mano ai diretti interessati: le controparti cipriote, la Turchia, la Grecia, Il Regno Unito – a motivo delle basi sovrane di Akrotiri e Dhekelia –, con l’UE a fare da contorno. Questa debolezza diplomatica compromette non solo la capacità dell’Unione di tutelare un proprio Stato membro, ma anche la credibilità della Politica Estera e di Sicurezza Comune, che resta subordinata agli equilibri nazionali.
La questione cipriota mette in evidenza, quindi, i limiti strutturali dell’attuale architettura europea e la necessità di un’evoluzione federale dell’Unione. Una Federazione Europea dotata di una politica estera e di difesa realmente comune consentirebbe di superare le divisioni nazionali che oggi paralizzano l’azione dell’UE in scenari come quello mediterraneo. Un’Europa federale disporrebbe della legittimità politica e degli strumenti decisionali per intervenire con coerenza, parlando con un’unica voce in contesti internazionali complessi e difendendo in modo più efficace i propri interessi strategici, energetici e di sicurezza. In tale prospettiva, la riunificazione di Cipro non sarebbe solo un traguardo regionale, ma anche un banco di prova per la capacità del continente di trasformarsi da semplice unione economica in un attore politico maturo, capace di garantire stabilità e ordine nel proprio vicinato.
{loadpositin AddThis}